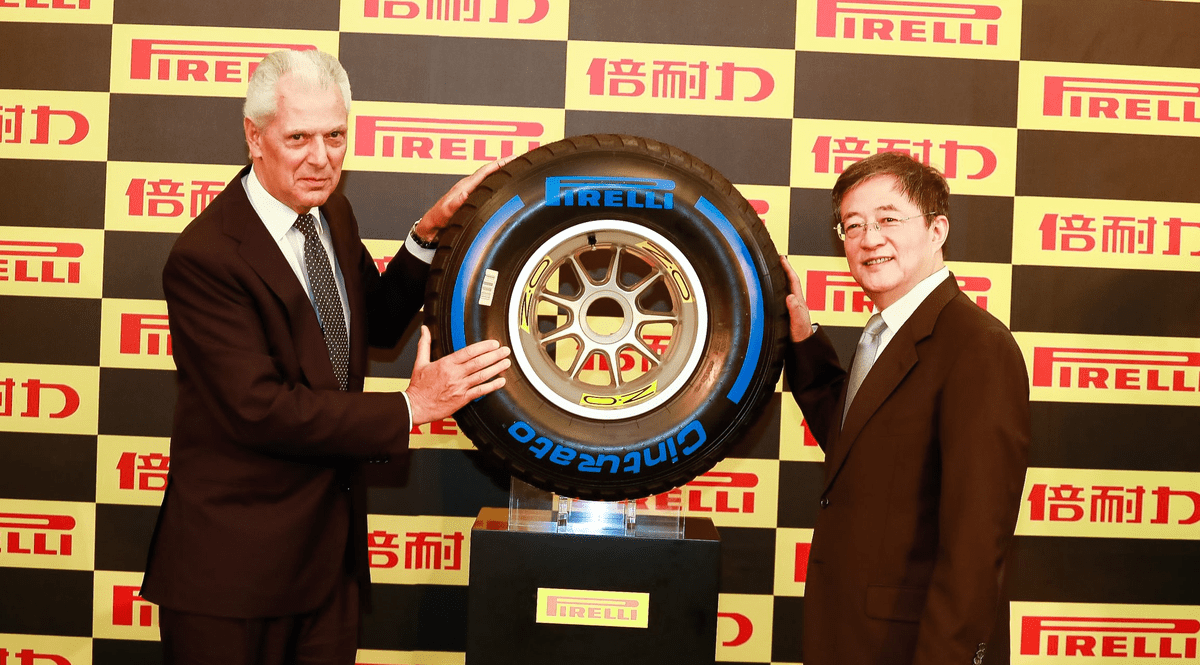Il governo ha scelto di utilizzare il golden power e mettere in sicurezza il controllo italiano di Pirelli. Non s’è levato un fiato critico, nessun oppositore s’è opposto e anche la stampa che solitamente dipinge Meloni come un rischio per l’Italia ne ha festeggiato la determinazione, elevandola a baluardo dell’Occidente democratico. Innanzi a tanta concordia nazionale non resterebbe che compiacersi. Quando si parla d’interessi reali si ottengono reali coesioni. Che bello. Se non fosse che il corale afflato si realizza su una mossa che introduce uno scivoloso precedente.
Vale la pena di capire, perché in questo racconto c’è moltissimo del capitalismo italiano senza capitali. Il primo azionista di Pirelli sono i cinesi di Sicochem, con 37,01%. Cinesi sono anche due altri azionisti, dal nome con un significato inequivocabile: Silk Road Fund (9,2%) e LongMarch (3,68%). In mano cinese si trova il 49,71% del capitale Pirelli. Il loro ingresso risale al 2015, quando i loro soldi servirono per sostituire i russi di Rosneft (con la Russia che aveva già preso la Crimea, nel 2014). Nell’azionariato Pirelli c’è una quota di Camfin, pari al 14,1%, che esercita un potere di voto largamente superiore, definito nei patti parasociali. Camfin viene indicata dai giornali come la finanziaria che fa capo a Marco Tronchetti Provera, ma il suo primo azionista è ancora la cinese LongMarch. Anche in questo caso i patti parasociali stabiliscono che gli italiani hanno diritti di voto superiori alle quote azionarie. In altre parole, ci sono azioni che contano di più pur avendo il medesimo valore unitario. Affari loro, resta il curioso fatto che questo genere di controllo societario viene denominato “scatole cinesi”. In questo caso piene di cinesi veri.
Nel 2020 gli Stati Uniti già indicavano quelle filiere cinesi come facenti capo ai militari e al governo, predisponendo le sanzioni. Mentre l’Italia non soltanto li aveva in casa, ma firmava gli accordi governativi per la “Via della seta”. Cosa è cambiato?
Da parte cinese (c’è un documento dello scorso novembre) le società azioniste di Pirelli – come tutte le altre importanti – sono state richiamate alla coerenza con i piani industriali di Xi Jinping. Dall’altra la Russia ha invaso l’Ucraina e la Cina s’è collocata al fianco di Putin, sebbene più per mangiarselo che per aiutarlo. Quindi, mentre gli azionisti cinesi cercano di fare quel che è ovvio nel nostro (nostro) sistema capitalistico – ovvero far corrispondere il potere ai soldi messi – l’azionista italiano si rivolge al governo segnalando il pericolo. Che si fa, considerando che non siamo in guerra ma c’è la guerra?
Esistevano due strade: a. vedetevela davanti a un giudice; b. si interviene a tutela di una tecnologia che ha a che vedere con la sicurezza nazionale, in questo caso congelando le azioni in mano cinese. Ma si deve indicare quale sia la tecnologia e che sia la geolocalizzazione delle ruote e l’accumulazione di dati in cloud è un po’ pochino, considerato che quella roba è a bordo di qualsiasi cosa e vettura. Il governo ha scelto una terza strada: afferma il valore strategico della tecnologia ma non congela le azioni, bensì modifica i patti parasociali, alzando il numero di consiglieri che Camfin può nominare. La Camfin in cui il primo azionista è cinese, sicché domani lo si dovrà forse rifare anche per Camfin.
Delle due l’una: o c’è la guerra e il capitale cinese non è gradito, in questo caso prima si prende una decisione politica d’indirizzo governativo (ma noi siamo ancora dentro la “Via della seta”) e poi si restituiscono i soldi, salutando; oppure si sta solo difendendo un azionista che ha messo soldi per la minoranza di quel che domina, introducendo un precedente che il cielo solo sa dove possa portare. Nel frattempo danneggiando tutte le imprese italiane – piccole, medie e grandi – che con i cinesi, da anni, fanno o provano a far affari.
Bella la concordia. O forse manca qualcuno che abbia saputo pensarci e voluto dirlo.