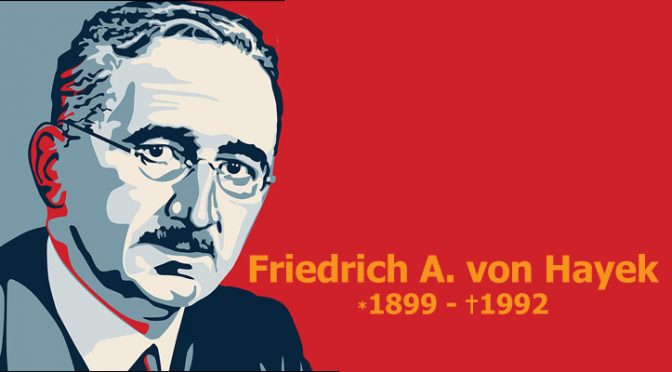Per chi voglia provare ad entrare, almeno un po’, nel dispositivo di pensiero di uno dei più importanti pensatori liberali, e non solo del Novecento, cioè Friedrich von Hayek (1899-1992), può essere utile leggere la bella raccolta di saggi curata da Lorenzo Infantino e che ora pubblica l’editore Rubbettino: Competizione e conoscenza (pagine 152, euro 14).
Sono sei saggi più o meno di occasione, ma non occasionali, che, collocati in ordine cronologico, aiutano a ricostruire genealogicamente, a partire dal suo “problema”, il pensiero hayekiano.
La conoscenza in economia
La questione che gli stava a cuore, Hayek la pose con nettezza in una conferenza che tenne a Londra nel 1936 e che figura, col titolo di Economia e conoscenza, come primo saggio della raccolta ora pubblicata: quale è il ruolo della conoscenza in economia? Può una economia centralizzata, o più in generale la pianificazione economica, farsene carico? E, ancora, lo si può risolvere attraverso la teoria dell’equilibrio economico generale?
Hayek dà una risposta negativa alla seconda domanda, ma anche alla terza.
E, in questo modo, si ricollega a Carl Menger, il fondatore della scuola austriaca dell’economia, e marca la differenza fra questa e le altre due scuole che avevano dato vita alla rivoluzione marginalistica o “neoclassica” di fine Ottocento e che ancora dominavano la scienza negli anni Trenta: quella anglo-americana, i cui massimi rappresentanti erano stati William Jevons e Alfred Marshall, e quella della scuola di Losanna facente capo a Léon Walras.
Le quali sulla teoria dell’equilibrio generale erano fondate in quanto facenti riferimento ad un homo eoconomicus razionale e calcolatore che, disponendo ab initio, di ogni informazione poteva calcolare appunto la migliore allocazione delle risorse a disposizione.
Era la tradizione utilitaristica che tirava le fila ai loro pensieri, mentre Menger se ne era subito discostato adottando una prospettiva che, già presente in Adam Smith (e in Edmund Burke), in genere nella “scuola scozzese” ma risalente a Bernard de Mandeville, potremmo definire evoluzionistica.
Più che un “illuminato calcolatore”, l’uomo mengeriano è ignorante e fallibile. È una creatura -scrive lo storico William Jaffé- “male informata, che erra, tormentata dall’incertezza, sempre esitante fra allettanti speranze e ricorrenti paure, congenitamente incapace di porre in essere, nel perseguimento dei propri scopi, decisioni ben calibrate».
L’uomo economico, per Menger come per Hayek, che estenderà negli anni questa intuizione a tutto il mondo sociale e umano, come documentano i saggi raccolti da Infantino, è in possesso di conoscenze parziali, mai complete e mai perfette e definitive, sempre sottoposte all’influenza delle altrui azioni, che partono da conoscenze altrettanto parziali e precarie.
È il tema della “dispersione delle conoscenze” umane nella società e dell’impossibilità che esse possano essere centralizzate da un decisore unico. Ogni programma politico-economico che non tiene conto di questa situazione fallisce miseramente.
Il che non significa che l’uomo non faccia piani e progetti (Heidegger diceva che egli è addirittura un “progetto gettato”). Ciò significa che questi piani individuali devono per forza di cose adattarsi alla realtà, cioè ai risultati passati delle azioni e piani degli altri uomini.
E, dall’altra parte, saranno tanto più efficaci in quanto riusciranno a prefigurare le aspettative future degli altri individui anche essi portatori nell’agire di loro personali progetti.
La concorrenza per Hayek
È tutta proiettata al futuro, mobile e imprevedibile per definizione, la concorrenza a cui pensa Hayek: una “logica della scoperta” non troppo dissimile, almeno nella forma, da quella che ha luogo nelle altre scienze. È l’ambito dello scambio economico e sociale che connota il mondo umano e che dà vita a un “ordine spontaneo” che va correttamente inteso come un semplice assestamento, cioè come un ordine intriso di disordine perché in movimento.
L’equilibrio postulato dalle teorie dell’equilibrio è inesistente: l’equilibrio che si dà nelle cose umane, fino a quando almeno esse saranno un risultato vitale e cioè della libertà, è sempre un equilibrio fra equilibrio e disequilibrio.
Si capisce perché il discorso da economico-sociale debba per forza per forza di cose farsi filosofico e concernere una teoria filosofica dell’azione umana (cosa che il maestro e compagno di Hayek, von Mises, farà in parte fatto col suo capolavoro Human Action che uscirà nel 1949).
Centrale, in questo ordine di discorsi, diventa anche la capacità umana di intuire le azioni degli altri, che, fra l’altro, su un terreno empirico, ha dato vita oggi ad algoritmi molto usati nell’economia finanziaria e che, secondo alcuni, fallendo (il che hayekianamente non dovrebbe essere un male), avrebbero causato la bolla speculativa all’origine della crisi del 2008.
Algoritmi che si pretendono sempre più efficaci ma che destano da un punto di vista filosofico non poche perplessità.
È come se l’esigenza di far da conto e rispettare la libertà individuale avesse finito per sequestrarla. Lungi questo esito però da Hayek, che proprio in difesa della libertà individuale, fondata sulla congenita e positiva imperfezione del mondo umano, ha messo in piedi tutto il suo meccanismo di pensiero.
La stessa concorrenza non può essere, né è auspicabile che sia, mai perfetta, e ciò proprio perché nella società si ha a che fare con esseri liberi.
La concorrenza è semplicemente il miglior modo per catturare in giro le conoscenze disperse e poter agire di conseguenza. “Tutto ciò – scrive efficacemente Infantino – significa che le relazioni di mercato alimentano una reazione chimica che rimane sempre inconclusa. Il processo ha carattere ateleologico”.
La fine di ogni pretesa finalistica, la messa in scacco di ogni filosofia della storia e filosofia politica (Gli errori del costruttivismo si intitola significativamente uno dei saggi qui raccolti), segna la messa in scacco di un secolo intero, il Novecento, che, come ha affermato qualche giorno fa in un articolo sull’Ottobre rosso un ex comunista del calibro di Biagio De Giovanni, è stato il “secolo metafisico” per eccellenza, con la sua pretesa che la storia avesse una ragione in sé intrinseca.
E non a caso nemmeno che la presunzione di conoscere sia il titolo della conferenza, pure riportata nel libro di Rubbettino, tenuta da Hayek a Stoccolma l’11 dicembre 1974, in occasione del conferimento del Premio Nobel per l’economia.
La tradizione per Hayek
La tradizione a cui Hayek fa riferimento, e che potremmo definire individualistico-scettica-evoluzionistica, è stata definita spesso “antirazionalista”. Hayek pure ha usato questa espressione, ma a un certo punto fa autocritica, perché foriera di malintesi, ed arriva a definirla “pericolosa e fuorviante”.
Qui più che la ragione, si vuole negare la pretesa afferrabilità a priori di una razionalità della storia. La quale, invece, è frutto spontaneo delle libertà individuali. Anche l’uomo razionale è fallibile e ignorante, ed è razionale, secondo il famoso monito socratico (“so di non sapere”), proprio perché è consapevole di questa ignoranza e fallibilità e mette in atto stratagemmi ragionevoli per fronteggiarla almeno un po’.
Sempre sul punto di contraddirsi, la ragione degli illuministi scettici è diversa da quella degli illuministi razionalisti che hanno allungato le loro pretese fino al secolo attuale.
È l’ “uomo di sistema” il vero nemico del liberalismo, l’avversario contro cui combattono Hayek e gli altri esponenti della tradizione di ricerca a cui egli si richiama. Bene fa perciò Infantino a riprodurre una bella pagina di Adam Smith tratta da quel vero capolavoro filosofico, per molti versi propedeutico alla Ricchezza delle nazioni (1776) che è la teoria dei Sentimenti morali (1759): “L’uomo di sistema – scrive Smith – è spesso così innamorato della presunta bellezza del proprio ideale di governo che non può tollerare la minima deviazione da qualunque suo particolare. Egli lo definisce in tutto e per tutto, in ogni sua parte, senza alcun riguardo per i grandi interessi o per i forti pregiudizi che possono opporvisi.
Sembra immaginare di poter disporre i diversi membri di una grande comunità così facilmente come la mano dispone i diversi pezzi degli scacchi sulla scacchiera.
Ritiene che i pezzi sulla scacchiera non abbiano altro principio di movimento che quello che la mano imprime loro, mentre nella grande scacchiera della comunità umana ogni singolo pezzo ha un proprio principio di movimento, del tutto diverso da quello che il legislatore può decidere di imprimergli”.
Come si è detto, il libro che Rubbettino ora pubblica mostra come in concreto Hayek sia andato sempre più allargando le sue intuizioni oltre l’economia, a tutto il mondo sociale. Fino a che punto il discorso sia in lui diventato speculativo e filosofico è questione controversa.
La risposta a questa domanda investe forse anche qualcuna delle ragioni, che Infantino liquida a mio avviso un po’ troppo frettolosamente, sollevate a fine Ottocento contro Menger dalla cosiddetta “scuola storica” tedesca.
L’economista austriaco si trovò in quel frangente a combattere su due fronti: da una parte con gli altri marginalisti, come si è visto, per differenziare, dalla loro, la sua posizione; dall’altra, con gli storici e scienziati sociali con cui dette vita a un epocale “controversia sul metodo”.
Il Methodenstreit, come con termine tedesco si chiama, iniziò nel 1884 con la pubblicazione di una recensione di Gustav von Scmoller alla Indagine sul metodo delle scienze sociali di Menger. E proseguì, negli anni successivi, con gli interventi di Karl Knies, Wilhelm Roscher e persino Wilhelm Dilthey e Max Weber.
In gioco era la stessa possibilità delle scienze economiche e sociali, con la loro pretesa di trovare leggi economiche generali senza tenere conto della dimensione storica che è propria del mondo umano.
Francamente, non mi è dato capire, a parte le contingenze personali dei maggiori esponenti della “scuola”, perché, come dice Infantino, le loro idee dovessero di necessità collocarsi, al contrario delle altre, in un orizzonte non liberale. Fatto sta, comunque, che la libertà e imprevedibilità della storia, che ai liberali stanno a cuore, sopportano fino a un certo punto i modelli astratti delle scienze empiriche.
Il pericolo alle porte, come diceva il filosofo inglese Michael Oakeshott, è sempre quello di costruire un modello per giustificare l’inesistenza di ogni modello. [spacer height=”20px”]
Corrado Ocone, Il Dubbio 14 novembre 2017